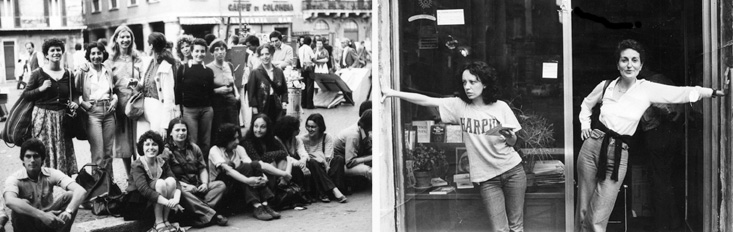di Franca Fortunato
Il 23 marzo 1944, in un pomeriggio di sole, nella Roma occupata dai nazifascisti, un gruppo di giovani partigiani dei Gap (Gruppi di azione patriottica), organizzazione clandestina armata del Partito Comunista, in via Rasella fa strage di tedeschi. Ritanna Armeni con il suo ultimo romanzo A Roma non ci sono le montagne edito da Ponte alle Grazie, ci catapulta in quel pomeriggio. Protagonisti sono giovani borghesi, colti, studenti, assistenti universitari o docenti, qualche operaio, che hanno scelto la lotta armata contro i tedeschi e i loro servi fascisti, in attesa dell’arrivo degli alleati (4 giugno 1944). Carla Capponi (nome di battaglia Elena), Sasà Bentivoglio (Paolo), Carlo Salinari (Spartaco), Franco Calamandrei (Cola), Maria Teresa Regard (Piera), Mario Fiorentino (Giovanni), Lucia Ottobrini (Maria): sono questi i loro nomi e quel pomeriggio ognuno/a è al proprio posto. Giorgio Amendola, dirigente del Partito comunista e componente del Cnl (Comitato di liberazione nazionale) e Spartaco, comandante del Gruppo, controllano che tutto vada secondo i piani. Tutto doveva avvenire entro le 14.00 quando il battaglione Bozen formato da 150 tedeschi, cantando e marciando, avrebbe attraversato via Rasella, secondo il racconto di Mario e Lucia che dalla loro finestra, ogni giorno, sentivano le voci e il rumore degli stivali. Tutti aspettano. Aspetta Sasà vestito da spazzino con il suo carretto pieno del tritolo portato da Carla, andando su e giù per le strade controllate dai tedeschi. Lei aspetta, con la borsa piena di bombe a mano, davanti al portone del “Messaggero” con un impermeabile al braccio che poi darà a Sasà. Tutti gli altri aspettano con pistole e bombe a mano costruite da Giulio, il giovane laureato in fisica. Perché i romani non prendono le armi, non si ribellano contro gli occupanti che in città seminano terrore e morte? «Perché – risponde l’autrice – a Roma non c’erano le montagne dove nascondersi come i partigiani del resto del Paese. Per nascondersi si poteva contare solo sui portici, sulle strade strette del centro, sui quartieri che in periferia si intrecciavano e si confondevano con le chiese o dei conventi. Le truppe naziste non si annunciavano, apparivano all’improvviso, sfilavano per le strade, perquisivano i cantieri, entravano nei portici. Toglievano il respiro […] sfinivano con la loro presenza». Terrore e odio seminava, insieme ai fascisti, Herbert Kappler, comandante della Gestapo, con arresti e torture. Aveva svuotato il Ghetto e deportato gli ebrei dopo averli ingannati facendosi consegnare 50 chili di oro in cambio della deportazione. Intanto a via Rasella il tempo passa ma dei tedeschi non c’è traccia. Sono alla festa nostalgica dei fascisti per l’anniversario della nascita del Partito (23 marzo 1919). Minuto dopo minuto l’autrice ci rivela i sentimenti contrastanti dei partigiani che stanno per annullare l’operazione militare quando alle 15.45 il battaglione arriva, marciando e cantando. L’esplosione è terribile, una strage (33 morti, un ragazzo lì per caso e molti feriti). I partigiani fuggono, i tedeschi sotto shock reagiscono subito, colpiscono le finestre, entrano nei portoni e nei negozi, fanno saltare le serrature, perquisiscono gli appartamenti, prendono i civili, compresi donne e bambini, separano gli uomini dalle donne. Da Berlino arrivano gli ordini di una rappresaglia esemplare che faccia “tremare il mondo”. Hitler vuole fucilati dai 30 ai 50 italiani per ogni tedesco ucciso, ma per paura di una insurrezione si decide 10. E fu l’eccidio delle Fosse Ardeatine (320 innocenti). Nella ricorrenza di quegli eventi come non pensare a Gaza dove, dopo il massacro del 7 ottobre, la rappresaglia è diventata genocidio di un popolo e le Fosse Ardeatine un abisso di odio, disumanità e morti tra cui migliaia di bambine/i innocenti?
(L’Altravoce il Quotidiano, rubrica “Io Donna”, 29 marzo 2025. L’Altravoce il Quotidiano è il Quotidiano del Sud che ha cambiato nome)