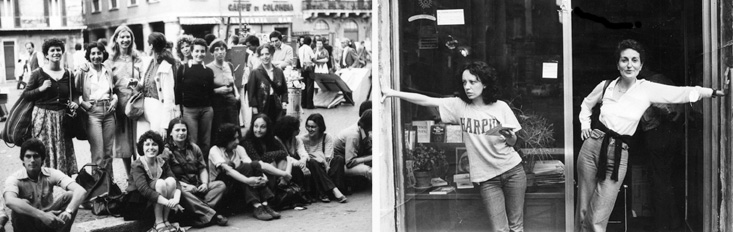di Jennifer Guerra
Hannah Arendt, Simone Weil e qualche riflessione su di noi
A fine gennaio ho dato un bellissimo esame di Filosofia contemporanea sul modo in cui tre filosofe, Simone Weil, Hannah Arendt e Rachel Bespaloff, hanno provato a interpretare quello che per tanto tempo ci è sembrato il periodo peggiore della storia dell’umanità. Sebbene non si siano mai conosciute, ci sono straordinarie coincidenze nella loro vita e nella loro produzione filosofica: tutte tre ebree (ma con un rapporto complicato con l’ebraismo), tutte e tre rifugiate, tutte e tre che partono dalla constatazione che gli strumenti e le categorie etiche o politiche tradizionali non servono più a niente di fronte all’enormità di quello che sta succedendo. Arendt e Bespaloff vivono tanto a lungo da vedere con i propri occhi l’Olocausto, Weil no, ma tutte cercano affannosamente un modo per fermare il flusso degli eventi, per mettere un cuneo, fermarsi un attimo e poter dire qualcosa.
Ho studiato questi testi¹ mentre leggevo due romanzi, Il Castello di Franz Kafka e Il complotto contro l’America di Philip Roth (di cui ho scritto brevemente nell’ultima newsletter) e mentre assistevo alla presa di potere inesorabile di Donald Trump. Io non so bene cosa ci riserverà il futuro, ma sono molto inquieta. Per anni le preoccupazioni di femministe, comunità LGBTQ+, persone razzializzate e altre minoranze sono state minimizzate e ridicolizzate, perché “vedremmo fascisti ovunque”, e altre variazioni sul tema. La forza di questa messa in ridicolo mi ha portata più volte a vergognarmi della mia paura in passato, ma onestamente in questo momento storico non ho alcuna paura di sembrare ridicola: ho paura e basta. E non so se sia stato il connubio fatale di queste tre cose – leggere un libro che descrive come si arriva al totalitarismo nella pratica, leggere un libro che descrive come si arriva al totalitarismo nella favola, guardare alle undici di sera l’uomo più potente del mondo fare un saluto romano e perdere il sonno per una notte intera – ma sto smettendo di pensare che quello di Weil, Arendt e Bespaloff sia stato il periodo peggiore della storia dell’umanità, perché c’è qualcosa ancora di peggiore, ed è quello di fronte a cui ci stiamo affacciando adesso, e per di più in un terreno in cui piantare il nostro cuneo diventa sempre più difficile. Un terreno vischioso e ingannevole, un’enorme sabbia mobile capace di una forza ancora più inesorabile di quella descritta da Simone Weil, che non si limita a farci cadere a peso morto a terra, ma ci trascina ancora più giù.
C’è un filo conduttore nel pensiero di queste filosofe, ed è il riconoscimento che in tempi orribili non ci sono differenze tra vincitori e vinti. Qualche giorno fa su TikTok ho visto i video di una ragazza trumpiana, talmente trumpiana da essere andata a Washington D.C. per l’inaugurazione, che è passata nel giro di poche ore dall’acritica celebrazione della vittoria del suo eroe al rendersi conto che l’esercito del suo eroe stava venendo a prendere il suo fidanzato, possessore di green card ma non cittadino americano. E così dai video tutorial su come fare gli alabama curls è passata a filmarsi in lacrime, senza mai chiedersi (o almeno senza ammettere pubblicamente) se c’era una connessione tra la sua fede MAGA e l’imminente deportazione del suo fidanzato.
Quando scrisse Le origini del totalitarismo prima e La banalità del male poi, Hannah Arendt si attirò molte critiche per aver osato dire che nel nazismo non ci sono differenze tra vincitori e vinti, perché il nazismo mira proprio ad annullare quella differenza. Quella differenza si annulla quando non c’è più possibilità di scegliere fra il bene e il male, e la massima aspirazione di ogni sistema totalitario è far sì non tanto che le persone smettano di compiere questa scelta, ma che non siano nemmeno messe nelle condizioni di provarci. Nei campi di concentramento, con il sistema dei kapò che prevedeva che fossero i prigionieri stessi a occuparsi dello sterminio dei propri simili, questa aspirazione era stata compiuta in maniera perfetta. Ma i lager sono appunto dei luoghi ideali, degli esperimenti intellettuali pur nella loro innegabile concretezza. Poi c’è il quotidiano, spazio e tempo di grandissimo interesse per Hannah Arendt, specie quando si trova faccia a faccia con Adolf Eichmann, funzionario nazista, impiegato anonimo e solerte, che tira fuori persino Kant per spiegare perché aveva fatto ciò che aveva fatto. Eichmann si giustifica piegando l’idea che non ci siano differenze tra vincitori e vinti a una sorta di vittimismo inaccettabile: obbedivo a un ordine. In nessun giorno della sua vita Eichmann si è mai chiesto quale fosse il prezzo della sua obbedienza. La sua vita quotidiana era scandita dall’obbedienza (“cadaverica”, scrive Arendt) a un ordine che forse gli era parso privo di contenuto. Messo di fronte all’evidenza di quel contenuto, Eichmann ha detto che non era colpa sua, ma del sistema in cui era immerso.
Questo mi ha fatto pensare, con le dovute differenze, al dibattito che si è scaturito all’indomani della vittoria di Trump negli Stati Uniti. Per colpa di chi ha vinto Trump? In molti ambienti di sinistra si è rigettata l’interpretazione secondo cui Trump è stato votato da una massa di rozzi elettori motivati dall’odio, descrivendo questo elettorato come un gruppo sociale sotto-rappresentato, abbandonato dalle élite democratiche, fagocitato dalla crisi economica. Un elettorato, insomma, che non ha colpe e che si è trovato costretto a votare Trump, in mancanza di altro. Capisco benissimo da dove arrivano queste interpretazioni, ma una parte di me non riesce a togliersi dalla testa che forse dobbiamo cominciare ad accettare che le persone che votano Trump e Meloni o che sostengono Israele e la pulizia etnica dei palestinesi lo fanno perché vogliono farlo, non perché sono costretti dalle circostanze. Perché credono in quelle promesse di dominio, violenza e ritorno all’ordine, perché odiano il diverso. Da femminista, non riesco a essere comprensiva verso chi ha votato in tutta coscienza un uomo che ha sacrificato la vita e la salute delle donne per il proprio tornaconto.
Arendt lo dice bene, benissimo: il totalitarismo ha bisogno del sostegno delle masse, ed è un sostegno che si nutre non tanto di violenza o persuasione (se fosse solo violenza, non avrebbe bisogno di consenso; se fosse solo persuasione, non avrebbe bisogno di violenza), ma che cavalca quella che Arendt chiama “incapacità di pensiero”. Quando parla di pensiero, Arendt non parla né di intelligenza né di cultura, perché anche persone intelligentissime e coltissime possono smettere di pensare. È interrompere consciamente un dialogo con se stessi. È smettere di porsi domande. È fingere che la distinzione fra bene e male non esista.
Mi ha colpito molto il passaggio in cui Arendt parla della coscienza: ogni cosa contiene in sé identità e differenza. Quando dico cos’è una cosa, dico anche cosa non è. E questo vale anche per me stessa: io sono io, cioè non sono un’altra, ma nel definirmi attraverso la differenza con l’altra, contengo in me anche l’altra. Fra le due parti di me c’è un conflitto, il “tribunale della coscienza”, dove una interroga l’altra, e viceversa. Per Arendt si smette di pensare quando questo essere “due-in-uno” smette di essere in conflitto, quando smetto di pensare la differenza nell’identità. Ed è molto facile che nel quotidiano si cominci a perdere qualche udienza di questo tribunale, che si perda interesse nei confronti di questa puntata infinita di Un giorno in pretura.
Prima ho scritto che i tempi di oggi mi sembrano infinitamente più spaventosi di quelli descritti dalle tre filosofe. In loro mi pare di scorgere, seppur dispiegandosi in modo diverso, la possibilità di un appiglio, una via di uscita. Il famoso cuneo. Quello che mi spaventa dell’oggi è che nel quotidiano siamo trascinati da forze oscure che non sappiamo nemmeno nominare, figuriamoci dominare, e che il nostro piccolo e stupido pezzo di legno non serve a niente.
Uno degli argomenti che accomuna Arendt, Weil e Bespaloff è la possibilità di fermare il tempo, anche solo per un istante, per poter almeno cominciare quell’azione di risalita. In Weil questa capacità si chiama attenzione. In Venezia salva, la tragedia che racconta la congiura fallita degli ambasciatori spagnoli per rovesciare il consiglio di Venezia nel 1618, il congiurato Jaffier decide di tradire i suoi compagni e far saltare il piano solo dopo essersi fermato un attimo ed essersi accorto di quanto è bella la città. Se non si fosse fermato, non avrebbe mai provato pietà per Venezia.
Io ho i miei dubbi che Trump, J. D. Vance o i broligarchi abbiano letto Simone Weil, però mi sembra spaventoso che proprio coloro che ci hanno così sfacciatamente derubato del nostro tempo, e quindi della nostra attenzione, ora siedano al fianco di un matto arancione nei suoi deliri di onnipotenza. I milioni di persone che hanno votato Trump, sapendo benissimo cosa stavano facendo², hanno rinunciato alla pietà e hanno scambiato l’attenzione che essa richiede per un surrogato. E in questo sì che davvero non ci sono differenze fra vincitori e vinti, perché non so voi, ma io mi sento esattamente sull’orlo di quel baratro. Col mio piccolo cuneo, che spero non sia poi così inutile come lo percepisco in questo momento.
(1) Nello specifico:
Simone Weil, L’Iliade, poema della forza
Simone Weil, Venezia salva
Rachel Bespaloff, Sull’Iliade
Rachel Bespaloff, L’istante e la libertà
Hannah Arendt, Sulla violenza
(2) Se c’è del paternalismo nel pensare che le persone che votano Trump sono cattive, c’è ancora più paternalismo nel pensare che sono stupide.
(Sibilla – Blog e newsletter di Jennifer Guerra, 6 febbraio 2025)